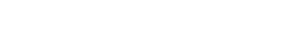CRITICA:
Ferruccio D’Angelo
La mia qualità di globtrotter dell’arte mi ha messo spesso nelle condizioni di essere presente, in prima persona, ai momenti salienti dell’arte internazionale.
Ricordo che, sin dai miei anni giovanili – avevo allora circa sedici anni – ho avuto la fortuna di vivere la grande stagione dell’Arte Povera torinese e di poter assistere alle performance di artisti come Pistoletto, Merz, Kounellis e tutti gli altri della allora “allegra” brigata dei poveristi, al tempo domiciliati presso Galleria Cristian Stein, in via Teofilo Rossi di Montelera.
Galleria posizionata al fianco di uno dei mitici locali notturni torinesi, quel Chatam che ha visto passare sul suo palco artisti internazionali, a poca distanza da uno dei locali del teatro “Off” torinese che ospitò in prima assoluta gli artisti del Living Theatre di New York che si esibivano nudi creando in verità un modesto scandalo, in una città che non si faceva scalfire dalle provocazioni e che affrontava tutto con quell’ understatement tipico torinese.
Ho visto la nascita della galleria di Gianenzo Sperone, già ragazzo di bottega della galleria Galatea, e le sue pazze installazioni, che incuriosivano un pubblico allora di nicchia.
Successivamente, le mie inquietudini e una serie di fortunate circostanze di lavoro, mi portarono ad uscire dalla cinta muraria cittadina e ad iniziare un vagabondaggio nel mondo dell’arte internazionale e a collaborare con tutte le più grandi istituzioni internazionali. Da lì i progetti di mostre e le collaborazioni con i musei di quasi tutto il mondo, le collaborazioni con gli artisti della neonata Transavanguardia: Paladino e Chia innanzitutto.
Ma, la vera scoperta, fu nell’ormai lontano 1993, quella della Cina e dell’arte cinese, oggi divenuta il fenomeno artistico del nostro tempo, ma allora ancora del tutto sconosciuta; proprio in quel periodo mi è stato dato di conoscere e frequentare gli studi di artisti in parte considerati clandestini, non solo nel loro Paese, poiché non uniformati alle direttive della Associazione degli Artisti cinesi.
In seguito, il prestigioso incarico di curatore delle Biennali d’Arte di Pechino mi mise nella favorevole condizione di poter collaborare all’ abbattimento delle barriere che ancora si opponevano alla liberalizzazione di un mondo artistico, in parte compresso. Il resto poi è storia del nostro tempo: le straordinarie performances artistiche e commerciali dell’arte cinese contemporanea e il grande interesse che attorno a questo Paese si sta sempre più verificando.
Ma tutto ciò non mi ha distolto dal seguire le vicende di casa mia, di vedere lo sforzo che Torino e il Piemonte stanno facendo per darsi una nuova identità, attraverso un percorso – quello dell’arte – che è ormai storicamente vincente per la riqualificazione di aree geografiche ed economiche, anche in parte depresse, valga per tutti l’esempio di Bilbao.
In questa prospettiva le iniziative di una città come Moncalieri ben si inseriscono e, in qualità di porta di ingresso di Torino, hanno in sè molte allettanti prospettive.
Dopo questa lunga premessa, veniamo quindi a Ferruccio D’Angelo, artista che, proprio in virtù di quanto da me scritto sopra, può a ben vedere rappresentare una sorta di cartina di tornasole di questa nuova presa di posizione nei confronti dell’arte e delle sue possibilità.
D’Angelo è sicuramente figlio di tutti quei fermenti di cui scrivevo prima e che si vedono affiorare all’interno della sua ricerca in una maniera sottile, quasi come un’eco lontana di un linguaggio che ha fatto già storia e che, nell’ambito torinese, ha creato nuove personalità e nuovi percorsi.
D’Angelo ha quindi assorbito quell’atmosfera di fronda artistica, non negandosi alcuna strada per la sua ricerca, sia attraverso installazioni di matrice post-poverista, sia nella rilettura di un ritorno alla pittura del tutto singolare e personale. D’Angelo non è un epigono, ma un sincero cultore dell’anarchia artistica, intesa come libertà espressiva e come unica strada percorribile per chi voglia lasciare dietro di sè un qualche messaggio, un sicuro riferimento per coloro che verranno dopo di noi.
Il mio girovagare tra Stati Uniti e Cina, tra Sud America e Africa, tra capitali europee e atélier di artisti di mezzo mondo, mi permette di collocare il lavoro di Ferruccio D’Angelo in un contesto sicuramente internazionale e di dare alla sua ricerca costante, instancabile, continua, una patente di internazionalità non conferibile a tutti e di credere nella sincerità della sua ricerca.
L’opera di Ferruccio D’Angelo è quindi storicamente collocabile al centro del dibattito artistico del nostro tempo, degna di essere comparata alle grandi figure dell’arte torinese.
Vincenzo Sanfo
1. L’ALBERO DELLA VITA L’ALBERO DELLA MORTE di Elena Pontiggia
2. L’ALBERO di Maria Teresa Roberto
3. UNA MIMESI TRA NATURA E CIVILTÀ di Martina Corgnati
4. UN OPERAIO di Francesco Poli
5. APPENDI UN QUADRO di Viana Conti
6. CINEMA di Renato Barilli
7. NATURA MORTA di Boris Brollo
8. PORTA D’ORIENTE di Edoardo Di Mauro
1) L’ALBERO DELLA VITA L’ALBERO DELLA MORTE di Elena Pontiggia
Sulla carta arricciata, affaticata dalla materia, bruciata o intrisa di nodosità, appaiono forme rotonde, che si gonfiano lentamente come funghi atomici, come organismi radioattivi.
Ferruccio d’Angelo li chiama alberi, li pensa come metafore vegetali, luoghi della vita, del suo riprodursi e del suo sottrarsi, così questa pittura, che si riallaccia per molti aspetti alle problematiche dell’informale ma anche a un rarefatto concettualismo, si colloca nel territorio fertile ed indistinto che dall’infinito del colore porta alla finitezza e alla definizione della forma. Di una forma, in questo caso, di cui è possibile una decifrazione naturalistica. La carta, la tela sono il luogo in cui, come in una torbiera, germinano e si formano i segni, le campiture, mentre le superfici si rapprendono piano, giungono ad un punto di condensazione e di consistenza.
Il linguaggio di d’Angelo, dunque, non si accontenta della disgregazione ultima della fenomenologia materica, ma tenta il procedimento uguale e contrario del ritorno alla forma. Le forme che si rivelano in queste opere, però, sono solo tracce. Ciprie mentali e polveri immaginarie di intonaco, screpolature e cicatrici, corrugamenti presunti concorrono a dare all’immagine una vaghezza allarmante. La tela sembra strutturarsi come una Sindone pagana, laica, su cui inspiegabilmente si disegna una presenza larvale.
L’albero, del resto, è una metafora ambivalente. E non solo perché, da un punto di vista simbolico e letterario, è insieme segno di vita (basta pensare, ad esempio, all’albero della vita della tradizione orientale o biblica) o di morte (in quanto è monumento funerario per eccellenza). Non si tratta solo di questo. L’ambivalenza è sottolineata anche, per rimanere più strettamente legati al piano della pittura, dal fatto che qui il tema, o meglio il motivo vegetale, si affida a colori terrosi, umbratili, notturni. Sono, quelli di d’Angelo, neri indecifrabili, grigi algidamente argentei, viola e gialli sulfurei, gamme di terre invernali.. spogliata di ogni festosità germinativa, questa pittura celebra un repertorio di assieme, di esistenze in pericolo, di memorie. E i minimi interventi decorativi che agghindano impercettibilmente le carte, non agiscono come ornamenti, ma come espressioni di artificio. E dunque sottolineano una condizione di improbabilità.. sarebbe però un errore soffermarsi troppo a lungo sui “contenuti” più evidenti del lavoro do d’Angelo, o meglio, sui contenuti verbali. Il vero “contenuto” di questa ricerca consiste piuttosto in una esplorazione del colore, delle sue valenze dagli scarti sottili e ai limiti della monocromia; consiste nell’accentuarsi delle dimensioni cromatiche attraverso l’apporto sommerso della materia, nel loro generare all’interno di sé un volume aereo e gassoso.
Tra graffi, filamenti, impronte la luce si manifesta su queste superfici con valori temporaleschi e minerali. Emerge a fatica, come da lontano, e resta imprigionata nel quadro come una possibilità anti-trascendente, come un attributo fisico e viscerale della materia. Non cade dall’alto, ma si sprigiona, per così dire, dal basso …
Elena Pontiggia
da “L’albero della vita, l’albero della morte”, cat. mostra alla Galleria Gabriele Fasolino, Torino, 1987
2) L’ALBERO di Maria Teresa Roberto
Se l’albero è simbolo della rigenerazione perenne, il ricorrere della sua immagine nei lavori di Ferruccio D’Angelo allude alla capacità della pittura di germinare in forme sempre nuove, di rendere fertili sempre nuovi supporti. La centralità dell’oggetto-albero, che si allarga e si dirama sopra e dentro il piano di fondo, elimina ogni distrazione paesaggistica, attirando il nostro sguardo sui tragitti di energia che collegano il basso all’alto, la terra al cielo, le radici alle foglie.
All’invarianza del tema corrisponde il differenziarsi delle sue manifestazioni: l’albero compare come correlato di fantasie di gemmazione, di fioritura, di arredo vegetale, oppure come catalizzatore di segni di violenza, come asse lungo cui si scaricano ed esplodono fuochi atomici. Nei piccoli formati l’oggetto cattura per sé tutta l’attenzione e il colore, i segni, i gesti sono diretti ad ancorare l’immagine al suo supporto. Nelle grandi dimensioni la figura è invece un’impronta che affiora, dilatandosi e galleggiando sulla carta o sulla tela. Tradotto in scultura, infine, l’albero torna ad identificarsi con la forma archetipica della colonna, ma attraverso la mediazione ironica dei materiali industriali. In ogni caso l’opera pare sottoposta alla pressione di una spinta interna, forzata da una segreta circolazione di linfa che agisce sotterraneamente gonfiando e venando le superfici, sgorgando attraverso le aperture.
In questo ritorno differenziato e pulsante di uno stesso motivo possiamo leggere il segno di un’attitudine riflessiva e distanziante che D’Angelo mantiene nei confronti del proprio operare, senza identificarlo né con l’invenzione della materia colorata, né con l’apparire di un’immagine, ma piuttosto con i gesti interiori mediante cui egli riesce a conservare l’equilibrio tra quei due poli.
Maria Teresa Roberto
da “Ferruccio D’Angelo” Unione Culturale Franco Antonicelli, Torino 1988
3) UNA MIMESI TRA NATURA E CIVILTÀ di Martina Corgnati
Il lavoro di Ferruccio D’Angelo presenta alcune componenti di eccentricità rispetto al tessuto culturale diffuso nella città in cui l’artista si trova ad operare. In alcune sue ipotesi visive si rinvengono i segni di un problematico interesse per i grandi temi dello spazialismo. Più che una forma di dipendenza culturale, sembra trattarsi di una vertiginosa curiosità per quel recondito velo di Maia che l’inconscio collettivo deve ogni volta tornare a squarciare. La superficie pittorica o plastica che occulta, attraverso la propria astratta bidimensionalità, non solo lo spazio ma anche la pregnante materialità di cui è composta.
Così Ferruccio D’Angelo ferisce l’epidermide della pittura – tesa verso l’assoluto della pura rappresentazione cromatica, rivelandone il sostrato banale, la carta; oppure la increspa in corrugamenti incidentali, capaci di interferire con l’implacabile esattezza della superficie. In altre parole, l’artista arricchisce continuamente col dubbio ciò che viene affermato.
Più recentemente, le sue opere incontrano lo spazio in un sistema di oggetti cavi-installazioni, a cui non è estraneo alcun tipo di tecnica e alcun tipo di materiale. Fra questi però Ferruccio D’Angelo mostra di prediligere i residui industriali o i prodotti di scarto, per costruire una propria mimesi della natura in certi elementi tipici, soprattutto gli alberi. Una natura nella civiltà delle macchine, evolutasi in un contesto urbano che può considerarsi espressione topica dei contenuti sociali di questa civiltà, trattata però con un tocco di leggerezza formale e di sorridente autoironia.
Martina Corgnati
da “Artinumbria”, n. 17, autunno, 1988.
4) UN OPERAIO di Francesco Poli
Tutto nel lavoro di Ferruccio D’Angelo appare di una disarmante semplicità e essenzialità: materiali poveri e valenze figurative appena indicate. Di qui nasce una singolare forza di impatto visivo, una suggestione scarna e suo modo intensa, tutta giocata sulla riduzione a una dura oggettualità, che lascia poco spazio ad eleganze formali, a rimandi culturalistici, a espressività oggettive, a tecnicismi più o meno virtuosi. Attraverso l’utilizzazione di bidoni, fili di ferro, graffette di rame, carta catramata, pluriboll, buste da lettere, ceste di vimini,, fili di ottone e zinco, fogli di giornali, sportelli in metallo, coperchi rotondi, l’artista arriva alla costruzione di oggetti e installazioni solo all’apparenza elementari, perché sono il risultato di un complesso processo di selezione e fissazione di un’intenzione creativa precisa. L’idea di fondo è quella di mettere in scena una sorta di omaggio al lavoro dell’operaio, alla sua fatica quotidiana anonima e ripetitiva, dove ogni aspetto di creatività individuale risulta annullata in funzione di una produzione in serie, standardizzata. D’Angelo propone una produzione alternativa: gli stessi materiali industriali, o meglio i residui e gli scarti, assumono una nuova identità, sono trasformati artigianalmente quasi per incanto in opere caratterizzate da forme e significati inediti. Opere che rimandano in particolare al tema dell’albero o a quello degli strumenti musicali (per essere precisi all’arpa). Nel primo caso, l’albero è inteso come simbolo di vita e anche di morte e rappresenta in modo volutamente ambiguo e problematico il rapporto fra dimensione artificiale e dimensione naturale, fra contesto urbano industriale e campagna. Nel secondo caso, materiali freddi, anonimi, la cui ragione di esistenza è strettamente connessa a una ben definita utilizzazione pratica, diventano il supporto di strumenti con una finalità assolutamente opposta: la produzione di musica, immateriale, effimera, spirituale, completamente “inutile”.
In ogni caso, al di là di queste indicazioni generali di significato, i singoli lavori presentati in mostra hanno un potenziale di senso e di effetti estetici, più complesso e articolato. L’albero è una specie di colonna alta circa due metri, formata da una serie di bidoni metallici ricoperti da una nera e bituminosa vernice antirombo, con una sola banda di colore blu: la cima è per così dire ornata da una corona di fili di ferro arcuati in fuori. È questo un totem, ironico e drammatico insieme, che appare come una radicale messa in questione dei valori più squallidi e angosciati dell’ideologia industrialistica. Un monumento provocatorio nella sua esibita primordialità plastica, nella sua programmatica assenza di qualsiasi effetto decorativo o comunque di piacevolezza formale. Ma non si tratta soltanto di una presenza in negativo. A guardar bene questo lavoro si può intravedere anche la volontà di dimostrare che ci sono le possibilità di una crescita della creatività e della libertà individuale dalle regole più ferree e costrittive della società del progresso produttivo. In tutto ciò, è bene precisarlo, non c’è retorica, né un’esibizione di “impegno sociale”. C’è la consapevolezza della complessità e delle contraddizioni di una realtà di esistenza in cui continuamente si rischia di perdere il senso e la coscienza dei valori più efficaci per la vera qualità della vita. Ironica e poetica è anche, in particolare, l’installazione a pavimento che per certi versi appare come il centro di attenzione della mostra. è una sequenza di ceste di vimini colorate in nero e blu, due vuote e tre colme di speciali fiori: sono fiori costruiti con un paziente lavoro manuale, di filo di zinco colorati in blu e nero e fili di ottone “nature”. Le ceste sono poste su un tappeto di fogli di giornali, metafore dello scorrere dei giorni e degli avvenimenti. Questi fiori artificiali (i fiori dell’albero) appaiono di una singolare freschezza: quasi un’offerta dell’artista allo spettatore, un invito alla riflessione, un augurio del superamento delle contraddizioni che la mostra stessa rappresenta.
Ancora legato al tema dell’albero e a quello della vita è un piccolo lavoro, che è una “sezione di tronco”, dove i cerchi concentrici tracciati con graffette metalliche segnano l’accumularsi degli anni della pianta. Uno sviluppo in chiave architettonica del tronco d’albero è “Arco di trionfo”, due colonne e un arco a tutto sesto, costruito sempre con dei bidoni. Il risultato è di una chiara evidenza nel senso della strutturalità primaria: dalla crescita naturale alla costruzione umana. In questo caso c’è, in un certo senso, un particolare raddoppiamento del vuoto(il vuoto dei bidoni e quello dell’apertura ad arco) ma con finalità costruttive. Valenze più poetiche si trovano nei due lavori sul tema dell’arpa, realizzati in modo diverso. Il primo sembra la dimostrazione dell’impossibilità della quadratura del cerchio: è un telaio circolare in legno dipinto di nero al cui interno, in una posizione un po’ eccentrica, è inserita una tela ricoperta da una superficie in pluriboll (materiale plastico per imballaggio), che sfondo a una sequenza di corde di zinco tese verticalmente. Il ritmo delle bollicine di plastica del pluriboll, vitalizzato da un dinamico gioco di riflessi luminosi, si oppone dialetticamente alla severa geometria circolare della cornice nera che riesce a ricomprendere solo parzialmente il rettangolo interno. Emerge qui una suggestione silenziosa di accordi formali e di contrapposizioni materiche: una musica silenziosa, fredda, artificiale, mentale, enigmatica. Viene da chiedersi: che cosa mai potrà suonare questo strano strumento e per chi mai dovrà suonare?
L’altra arpa è un piccolo rettangolo realizzato con uno sportello di un armadietto Olivetti. Nell’apertura in centro sono tese delle corde in zinco. Questo lavoro, che non concede nulla alle esigenze formali della composizione, ha un aspetto più ermetico e forse più affascinante.
Relativamente spiazzante, bizzarro, è un piccolo lavoro intitolato “Autostrada”: uno sciame di graffette metalliche che si allontanano verso il fondo, su un supporto di carta catramata. Da citare la motivazione dell’opera scritta dall’artista: l’operaio dopo una giornata di lavoro immagina il suo ritorno a casa.
Anche se si possono ritrovare numerosi riferimenti più o meno esplicitamente dichiarati, il lavoro di Ferruccio D’Angelo ha qualcosa di stranamente inafferrabile, qualcosa di disarmante: insieme alla chiarezza di intenti, non è assente una volontà di impegno sociale, c’è un senso di solitudine e di unicità degli oggetti artistici che sembra rifiutare una spiegazione immediata. Qualcosa di sottilmente inquietante che si insinua nelle pieghe dei materiali e in quella che è l’apparente ragione dell’elaborazione artistica. Si lascia aperto all’osservatore un ventaglio aperto quasi a trecentosessanta gradi di possibilità interpretative pur indicando una definita area d’identità del lavoro.
Francesco Poli
da “Un operaio”, cat. mostra allo Studio Noacco, Chieri 1989
5) APPENDI UN QUADRO di Viana Conti
Appendi un quadro è il titolo di un “quadro” che Ferruccio D’Angelo appende in galleria per una mostra personale. Si tratta di un coperchio rotondo, cernierato, tinteggiato di nero e con un gancio fissato al centro, in alto, giusto davanti all’osservatore. Il gancio guarda chi guarda. Perché? L’asetticità dell’iscrizione dice quello che tace, avvia il discorso sulla mitologia del quadro e su tutte le decisioni e le scelte che precedono il momento dell’appenderlo. È un gesto che esclude tutti gli altri e che si afferma negando. Afferma l’oggetto come quadro e lo nega come coperchio, lo nega come superficie da completare e lo afferma come gancio. Su questa piccola presenza, che l’artista investe di grandi possibilità, si affolla una moltitudine di gesti, immagini, occhi. “L’arte pesa” diceva anni fa Ben Vautier, “ma questo minuscolo uncino può sollevarla da terra”, ribatte oggi D’Angelo.
Nel suo viaggio verso il destinatario un’altra opera di questa mostra torna al mittente sotto forma di lettera: l’autore scrive a se stesso l’iscrizione della sua lettura. Nella volontà di un contatto estremo tra l’artista e la sua mostra, si ottiene un effetto-specchio, dove l’opera si produce come metaracconto. Prossimità e distanza, opacità e trasparenza giocano la loro partita senza fine. Ma al di là del ritratto di un vetro non c’è che il muro cui una cornice, cintura attorno al nulla, conferisce lo statuto di opera.
Viana Conti
da “Ferruccio D’Angelo”, Galleria Pinta, Genova, 1989
6) CINEMA di Renato Barilli
Il lavoro di Ferruccio D’Angelo rappresenta molto bene alcune caratteristiche comuni alle nuove leve della ricerca artistica. In primo luogo vi domina l’oggetto, una fame di realtà che porta ad evitare ogni specie di finzione rappresentativa. Il “ritorno alla pittura” che aveva caratterizzato la situazione di appena dieci anni fa, appare assai remoto, sconfessato. Gli oggetti, a loro volta, hanno un piglio freddo, si avvicinano molto, fin quasi a confondersi, agli oggetti funzionali, anonimi, seriali del nostro décor quotidiano, potentemente segnato dall’industria. Siamo insomma nel regno del “ready made”, e D’Angelo non fa certo eccezione, distinguendosi semmai, al pari dei suoi coetanei, per il desiderio di allargare sempre più l’ambito stesso del “ready made”, di abbracciare cioè fette di realtà via via più ampie, smisurate. Nel suo caso, per esempio, viene coinvolto un intero cinema, con le poltroncine tutte uguali, irreprensibili.
Ma non mancano di scattare, però, elementi “ al recupero”, volti ad imprimere un marchio di originalità su tanta trionfante stereopatia, anche se perfino questi indici stranianti si propongono di mantenere un’aria asettica, fredda, impassibile, non danno certo nello sbracato. D’Angelo, per esempio, ricorre a una fasciatura elementare, ancorché effettuata con materiale neutro, ma basta lo stesso per dare a quei suoi soggetti di solido design un’aria di mummie. Chissà, vivessero oggi, i solerti sacerdoti e tecnici delle pompe funebri che organizzavano il corredo di suppellettili chiamato ad accompagnare il faraone, nell’aldilà, non trascurerebbero, appunto, di fasciare a quel modo gli immacolati mobili “svedesi” del suo interno domestico… Oppure, altra associazione, mi vengono anche in mente gli scuri barili bituminosi del petrolio: come se queste sedie di D’Angelo risultassero dal montaggio di tante taniche, solenni, massicce, persino funeree… Col che, evidentemente, pur partiti da tutt’altra direzione ritroviamo la seria di metafore e similitudini precedenti. E dunque, questi oggetti, nonostante la simulata scostante freddezza, esprimono, emettono le onde di un coinvolgimento psichico. Dalla realtà tale e quale deviamo verso l’arte.
Renato Barilli
da “Cinema” cat. della mostra, Galleria Piero Cavellini, Milano, 1991
7) NATURA MORTA di Boris Brollo
NATURA MORTA come vanitas; natura morta in quanto specchio di una realtà surrettizia non più legata ad un riferimento concreto ma virtuale: MATERIAL NATURE…
… Troviamo Ferruccio D’Angelo ripercorrere le strade africane dell’Egitto in cerca di “Porte” che sono ormai ridotte a icone virtuali, simboli di storie infinite: significati di cui si è perso il bandolo della memoria. Che sia l’arte un labirinto infinito? Solo che non c’è tempo oggi per la sua verifica, pena la propria sconfitta. Eccole allora nascere come idee queste nature morte e queste porte, ma non debbono nemmeno strutturarsi in atti concreti pena il loro fallimento, esse debbono rimanere idee, intuizioni, quindi pellicole dove l’intento di D’Angelo è solo adatto ad assecondare la loro naturale inclinazione e non a caricare o a correggere, dandogli così un loro carattere, come già avveniva in Warhol. Assecondare non interferire in quanto non vi è più nessuna missione da compiere o ideologia da salvare come dice Kundera. L’arte è neutra come il capitale. Essa assume carattere solo su ordinazione o chiamata in causa, inoltre per sua natura non è più struttura bensì puro pensiero che si presta ad essere operativo: mossa duttile, il che la rende sempre splendente e rinnovabile. D’Angelo ha capito questo: che essa arte o natura naturata è sì finita e quindi “morta”, ma appunto per questo illimitata.
Boris Brollo
Da “JULIET” – Art magazine”, n. 62, 1993
8) PORTA D’ORIENTE di Edoardo Di Mauro
Il progetto artistico di Ferruccio D’angelo si forma e prende corpo negli anni ’80, un’epoca in cui domina un clima di multidisciplinarietà ed un’esaltazione dell’immaginario metropolitano. Seguendo dapprima una linea di rinnovamento del linguaggio della scultura e dell’installazione, sia dai canoni del monumentalismo d’avanguardia, sia da quelli dell’Arte Povera. È da quel tracciato che trae inizialmente ispirazione il lavoro di D’Angelo, sebbene subito discostandosene, non accettando sudditanze né di tipo formale, e ancor meno psicologiche. In realtà il riferimento è stato soprattutto indirizzato nei confronti di una elementarità ed archetipicità dei moduli espressivi prescelti. Nei fatti il rapporto possibile, e nel primo caso idealizzato, tra artificio, inteso come tecnologia, e natura è stato da D’Angelo invertito nei termini, con un netto predominio formale del primo, in accezione simbolica, rispetto al secondo. I bidoni riciclati, dipinti monocraticamente con tempere acriliche blu e nere ed altre vernici, rappresentano, ad onta dello spunto iniziale, un superamento delle tematiche classiche dell’installazione concettuale, rivolto in direzione di un funzionalismo provocatoriamente vicino alle forme più recenti del design, come nel caso delle grandi sedie oggetto di una personale nella galleria milanese di Piero Cavellini nel 1991 e poi riproposte, sempre con successo, in varie altre occasioni nel corso degli anni. Anche quando oggetto della proposta è l’evocazione della natura, come nel caso dei tronchi d’albero e di altre soluzioni visive affini, il risultato è quello di un’immagine rigorosa formalmente, come un minimalismo aggiornato ai nostri giorni, ma al tempo stesso ludica, al pari dell’artificio assoluto tipico dei principali esponenti dell’oggettualismo pop italiano, come Gilardi e, soprattutto, Pascali.
Accanto alla vocazione installativa, l’artista torinese ha perseguito negli ultimi anni nuove ricerche formali, alcune delle quali, le più recenti, sono oggetto di questa personale. Dapprima la fotografia, a colori ed in bianco e nero, riproducente le installazioni stesse, con un risultato finale ambiguo e straniante. Successivamente con la proposta di sculture da interno, ancora più vicine all’universo dello stilismo e del design, e fede ne fa la partecipazione a varie rassegne internazionali dedicate alla contaminazione tra l’arte visiva e le sue varie applicazioni funzionali. Poi ancora con una pittura curiosa, minimale, proposta su superfici atipiche, prodotte con oggetti riciclati. Nell’ultimo biennio l’artista si cimenta con una serie di lavori dal felice esito estetico. Vi è nuovamente il preciso richiamo alla pittura, ma non più in dimensione minimale. Si potrebbe semmai parlare di un’attenzione rivolta al barocco, di una voluta teatralità e ridondanza dell’immagine. Un barocco contestualizzato in una dimensione presente. Prova né è il richiamo “secondario” nei confronti della tecnologia, in particolare ai fotogrammi di immagini televisive e pubblicitarie. Queste non sono, però, proiettate sulla tela adoperando unicamente il ricalco fotografico. D’Angelo reinventa l’iconografia con una modifica dei toni graduale, prodotta con colori ad olio ed una prassi rigorosamente “classica”. In questo modo si ottiene un reale straniamento e non una suggestiva, ma in fondo banale, riproposizione dell’originale, tanto in voga oggi, con la coltre mimetica del colore che si sovrappone alla fotografia. I temi prescelti dall’artista si pongono in stridente opposizione rispetto all’insopportabile “international style” di cui sono colme le pareti di gallerie e musei. Vi è, al contrario, una rivendicazione profonda ed orgogliosa delle nostre radici mediterranee. D’Angelo, calabrese di origine, per meglio dire di quella parte della Calabria storicamente imparentata con la Grecia, trae il suo repertorio da inquadrature tratte da quel variegato mondo che si pone al confine tra Occidente ed Oriente, oggi attraversato da tensioni di molteplice natura. Da un lato il voler guardare alla cultura europea di cui è stato padre, mantenendo al tempo stesso l’orgoglio della propria tradizione e diversità. Dall’altro, come nel vicino Medio Oriente, essere squassati da una violenza che da cinquant’anni non conosce sosta e costituisce una delle pagine più vergognose della cultura e della politica occidentali. In Ferruccio D’Angelo la sintesi, formale ed ideologica, di queste opposte tensioni, si estrinseca in opere di grande fascino visivo e complessità, in grado di scuotere positivamente la sensibilità del fruitore.
Edoardo Di Mauro
da “Porta d’Oriente” cat. a cura di E. Di Mauro, W. Accigliaro, B. Brollo, Castello Comunale, Barolo (CN), 2001
9) LETTERA INVIATA ALL’ARTISTA DAL COLLEZIONISTA dr. Pietro Molinas
… Se nell’oggetto c’è la materialità dell’arte mentre nel concetto c’è il pensiero dell’artista, mi rendo conto che hai da sempre guardato alla natura (qui sta la tua idea) per attribuirle ciò che l’homo faber le sta togliendo, ossia la sua dignità, il suo aspetto e la sua funzione. In tal modo, la tua rivelazione artistica restituisce alla natura la sua essenza… Nella tua opera complessiva, fatta di grande pittura, esiste ogni volta l’idea della purificazione e della germinazione, dell’eterno ritorno, ed in fondo, quando guardi ad oriente ti fai illuminare dal sole imperioso che nasce, invitando il fruitore a reinserirsi nella natura per arricchirla e magnificarla…
… Se dopo Auschwitz non c’è più poesia e dopo Picasso non c’è più pittura, possedere qualche tua creazione costituisce un privilegio riservato a collezionisti impastati di sensibilità e spiritualità. Comunque non ti sarà facile essere apprezzato nella nostra patria, perché l’italiano ha perso o sepolto la propria coscienza, essendo succube della volgarità espressa dai media televisivi, dalla classe dirigente e dalla massa tipicamente pallonara. Dove si annida nel nostro paese il magnifico pensiero italiano dell’artista, del letterato, dello scienziato? Per quali verità la nostra arte contemporanea è attualmente asservita al poverismo e alla transavanguardia?
Si è manipolato decisamente in basso il senso dell’onore, dell’etica e dell’umiltà, ed una nutrita schiera di cafoncelli presuntuosi e ciarlatani mistificatori gestisce ormai il palcoscenico della nostra società. Perciò, cosa può esprimere l’arte dei nostri giorni, valutando che prima è stata stravolta da Picasso e da Duchamp, poi si è fatta schiava degli intrighi e degli affari, infine è stata sfruttata dai compromessi dello spettacolarismo voyeristico! È mai possibile che nessuno dica o scriva che tuttora all’estero viene denominato “italiano”, e quindi ampiamente elogiato, l’artista sapiente, ricercato, distinto e attraente!
Meno male che non si è bendati e sordi e che di verità ce n’è una soltanto: risulta ben evidente che la storia si ripete sempre, che il tempo vela e rivela, e che lo spazio postula l’infinitamente grande. È semplicemente indispensabile e sufficiente che l’identità eccezionale della pittura italiana sia protetta da un sistema dell’arte altrettanto eccezionale. Leggerti con attenzione significa capire che i tuoi bidoni riciclati sono un inno all’astersione della materia e, magari, rappresentano la metafora del contenimento dell’intera spazzatura artistica italiana..
Con gli ultimi lavori pittorici decostruisci il mito del consumismo, svaporandolo con l’intento di rendere più appariscente il messaggio culturale che promana da certi simboli del passato (vedi la sfinge che ritorna ad essere vista nel suo aspetto di enigmatico monumento egizio anziché come effigie di una conturbante marca di tabacco). E con la fine del tabagismo, la natura si riappropria di quella pianta che per edonismo l’uomo ha manipolato in modo da danneggiare il proprio organismo; così la natura deteriora oggigiorno se stessa come l’arte, per il piacere del suo sistema, compromette attualmente se medesima.
… Un altro fattore si aggiunge al cammino della tua formulazione estetica: il vento il quale, trasportando la visione nell’oriente estremo, consente l’incontro di una cultura fondata sul giallo assoluto e travolgente. Così, in taluni recentissimi dipinti, i toni del giallo squarciano la fiamma lucente della spiritualità… Nel vento suadente c’è il soffio, lo spirito celeste; da qui il tuo destino è inciso in natura da un trittico di elementi: il calore, il colore e il soffio…
Pietro Molinas
Estratto da una lettera inviata all’artista dal collezionista dr. Pietro Molinas